Recensione del libro: Cartagloria Premio Letterario Pozzale Luigi Russo
Rosa Matteucci
Cartagloria Adelphi 2025
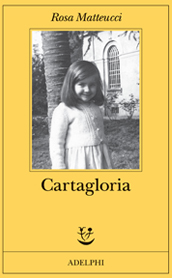 Recensione di Mariangela Giusti
Recensione di Mariangela Giusti
La prima parte di Cartagloria si configura come un romanzo di formazione: l’autrice racconta nella forma del romanzo autobiografico il suo mondo di bambina -e poi di ragazzina- che nasce, cresce e si forma in una città di provincia dell’Italia centrale. Solo dopo molte pagine il lettore scopre che si tratta di Orvieto, ma il nome della città sembra non essere rilevante. È importante invece, il contesto familiare della protagonista e la casa o per meglio dire l’antica villa nobiliare nella quale è nata e cresciuta. La villa e il grande giardino intorno rappresentano lo sfondo della sua vita di bambina, sempre a contatto con la natura e gli animali (i molti cani di varie razze…). La villa, con le tante stanze e la cappella privata, è rammentata e descritta come luogo privilegiato da cui apprendere la vita, le sue potenzialità, i suoi drammi e i suoi misteri. Ancor di più contano nella formazione della bambina/ragazzina le figure familiari, sia quelle reali della quotidianità, sia quelle della memoria di tante vicende raccontatele da altri e immaginate. Attraverso il racconto di episodi ora tragici ora ironici incontriamo i nonni nobili anziani, la zia madrina del suo battesimo, una misteriosa prozia che aveva lasciato proprio a lei (alla protagonista) un “legato” in eredità (ma ad alcune precise condizioni difficili da rispettare), la madre, il padre, la sorella maggiore. Una famiglia con una lunga storia dietro le spalle. Poi, come talvolta accade nella vita di tante famiglie, le rendite incominciano a vacillare “la proprietà terriera del nonno costituiva una spesa insostenibile, il contante scarseggiava, finché non scomparve del tutto” (pag.21). Questa indigenza, all’inizio non palesata alla bambina da parte degli adulti, diventa sempre più evidente nella vita e nelle esigenze di tutti i giorni (per esempio, lei non aveva neppure una cartella “vera” per andare a scuola…) e condiziona la sua crescita. Dunque, Cartagloria ci dice che si apprende dai luoghi in cui viviamo; si apprende dalle esperienze che siamo costretti a vivere e anche da quelle che noi stessi ci procuriamo; si apprende stando con gli altri perché ci mettono alla prova; si apprende anche da un’idea indistinta che avvertiamo dentro di noi di “trascendenza”, difficile da definire, ma che ci accompagna dall’infanzia all’adultità e a cui sentiamo di dover dare qualche risposta.
Fin dalle prime pagine del libro è messo in evidenza lo stretto rapporto che c’è fra l’esistenza, la crescita e la religione. Nel caso della protagonista del romanzo, tale rapporto è stato segnato fin dall’inizio da una “mancanza” perché, proprio a causa dei problemi finanziari della famiglia, nessuno degli adulti (né i genitori, a cui ovviamente spettava il compito, né la nonna…) la iscrive al catechismo per la preparazione alla prima comunione. Non potendo frequentare il catechismo, non può neppure ricevere la comunione, come tutti gli altri bambini e bambine della sua città e della sua età. È un fatto, questo, che crea una frattura, un segno di diversità fra lei e gli altri, che nel corso della vita si è in parte colmato, ma mai del tutto. Rosa Matteucci dedica diverse pagine del romanzo all’episodio della mancata prima comunione, utilizzando toni accorati e autentici, ma anche comici. Infatti, la bambina-Rosa, anche senza aver fatto il corso preparatorio, decise di vestirsi come meglio poteva e di presentarsi ugualmente in chiesa (con ai piedi le ciabattine infradito, oltretutto), sistemandosi in fondo alla lunga fila dei comunicandi al fine di ricevere (anche lei, come tutti!) la sacra ostia. Un episodio tutto giocato e descritto sul filo del paradosso, dunque divertente alla lettura, come ce ne sono altri nel libro. Eppure, è un episodio efficace nell’intento di mostrare la profonda significatività del rito, di qualsiasi rito che rimanda al mondo trascendente (in quel caso, era il rito della prima comunione). Questo argomento attraversa tutto il libro ed è il filo che collega i capitoli: ogni rito, ci dice Rosa Matteucci, di tutte le religioni, contiene allo stesso tempo elementi sacri e profani e segna i percorsi di vita delle persone. Infatti, per i motivi più vari (viaggi, curiosità, ricerca dello spirituale, bisogno di aiuto…) la protagonista di Cartagloria si avvicina a riti sacri e a momenti di culto di varie religioni. E li descrive ai lettori con molta accuratezza. Si reca in India a vivere l’esperienza del Maha Kumbh Mela, il bagno sacro nel Gange di milioni di fedeli indù; partecipa a momenti rituali del buddismo Sokka Gakkai; si reca da volontaria alla grotta sacra di Lourdes con il treno dell’Unitalsi; ricerca caparbiamente l’incontro e le formule misteriose di un frate esorcista; infine prende parte con sincera devozione alla messa tridentina celebrata in latino in una chiesa di Lavagna. Il libro racconta molte vicende autobiografiche, che, grazie alla ricchezza del lessico e all’accuratezza del racconto, diventano universali.